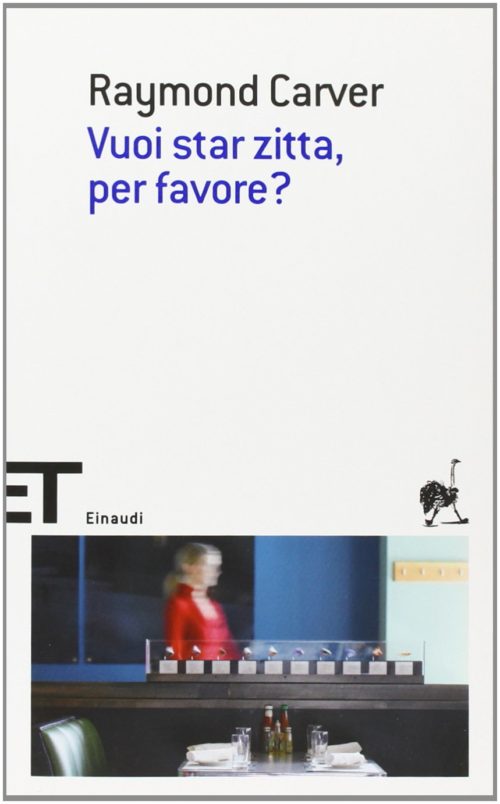L’io è finito perché deve essere delimitato, però
in questa finitezza è infinito perché il confine
può essere spostato sempre più in là, all’infinito.
È infinito secondo la sua finitezza
e finito secondo la sua infinità.
J.G. Fichte, Fondamento dell’intera dottrina della scienza, 1794-1812
Non ci sono dei precisi motivi ricorrenti. Non ci sono descrizioni né personaggi indimenticabili. Non ci sono nemmeno una logica, una morale, un messaggio facilmente decifrabili. Leggere Raymond Carver non è un’esperienza semplice. La sua è una scrittura tecnicamente impeccabile, incredibilmente vicina alla vita, ma ogni singolo dettaglio conduce a una dimensione altra rispetto alla vita; ogni singolo dettaglio diventa immagine simbolica che mentre accenna al minimo fa vedere il tutto; immagine intuitiva il cui possibile significato si distende oltre la mera processione degli eventi. Considerare i racconti di Carver come dei modelli di letteratura minimalista è quindi estremamente riduttivo. Carver è solo in apparenza uno scrittore minimalista. Carver scrive l’Assoluto.
Solitamente, nei suoi racconti emerge il senso di inadeguatezza nei confronti di un particolare evento e di incompiutezza nei confronti della forma generale che la catena degli eventi della propria esistenza potrebbe o dovrebbe assumere. In altri termini, le persone non sanno cosa fare; ma non solo ora, nella situazione determinata dal racconto, non solo a un certo proposito, non solo oggi o domani, ma tutti i giorni che rimangono loro su questa terra.
La sua scrittura si focalizza sulle cose più piccole e apparentemente insignificanti, ma non ha alcuna pretesa di raccontare la verità. Tutte le parole sono disposte nella loro posizione più assoluta. E dietro ogni frase, così squallidamente perfetta, si apre uno sconfinato orizzonte di tristezza. Di pura, inesorabile, tristezza. E tutto parte dal banale susseguirsi di minuscoli eventi o variazioni d’animo.
Ciò che rende la scrittura di Carver un monumento, tuttavia, non è tanto da ricercarsi nell’impeccabilità tecnica della scrittura, bensì nel risultato essenziale di quest’ultima, che potrebbe essere definito il domino del non detto. Grazie a questo effetto, l’autore pone la necessità metafisica di esaminare un avvenimento isolato di una singola vita e a cogliere in esso i microscopici segnali della catastrofe che da quel momento in poi cambia l’intero corso di quella stessa vita. Carver coglie le vite nel loro scorrere, nel loro spezzarsi temporale, e coglie dei frammenti in cui quelle vite si fermano, specchiandosi nell’atroce eppure impellente bisogno di trovare un senso globale alle proprie azioni.
Credo che il traduttore di questa raccolta di racconti abbia preso un abbaglio sostenendo che ‘mescolato al disincanto con cui Carver sa raffigurare alienazioni e mancanze, spunta qui e là un tratto più emotivo, passionale, in qualche caso un dettaglio erotico o comico. In una parola, una qualità affettuosamente umana’. In primo luogo, perché quelli non sono affatto dettagli, ma momenti che racchiudono un tutto narrativo. In secondo luogo, perché Carver non prova alcun affetto per l’uomo, ma lo denuda nel suo squallore, nella sua debolezza intrinseca.
Per Carver c’è una grande malvagità che preme sul mondo, una malvagità assoluta che ha bisogno solo di uno spiraglio, di una (questa sì) minima fessura per riversarsi in esso, come un’esplosione improvvisa che imbratta ogni cosa di nero.
Minimalismo, per Carver, significa soffermarsi sulle cose minime. Le cose minime rappresentano il limite esistenziale dell’uomo, e il soffermarsi su di esse implica il proiettarsi in una dimensione onirica, al di là della realtà, tornando poi ad osservarla da una prospettiva tragicamente universale. Il passaggio dalla realtà alla tragedia è consentito, più che da un elemento erotico o comico, da un elemento grottesco. Il passaggio dalla realtà al sogno, da piccolissimi dettagli, limiti che aprono a una dilatazione drammatica e potenzialmente infinita dell’io. Cavalli bianchi, ad esempio. Una delle poche figure nitide rintracciabili in diversi racconti di Carver: ‘Spostò tutta l’attenzione su una delle minuscole diligenze nere stampate sulla tovaglia. Quattro minuscoli cavalli bianchi trainavano scalpitando ciascuna diligenza nera e la figurina del postiglione aveva le braccia alzate e indossava un cappello a cilindro, e sopra le carrozze erano legati i bagagli e appesa da una parte c’era quella che sembrava una lampada a cherosene e, se lui stava ascoltando, lo stava facendo dall’interno della diligenza nera’.
Nell’esempio riportato, una persona ascolta dall’interno di una diligenza nera trainata da cavalli bianchi, interagisce con la realtà a partire da un luogo decisamente irreale. Il primo stimolo è dato dallo sguardo che si sofferma su una cosa minima (il disegno della minuscola diligenza), ma questo soffermarsi sul dettaglio, sul minimo oggettivo, trasferisce la parola nell’assoluto soggettivo – la parola adesso proviene non da una diligenza disegnata sulla tovaglia, ma viene filtrata dal confine che porta a una diligenza che si muove oltre la tovaglia – e il non saper cosa fare della persona che ascolta si riveste di un valore superiore, si trasforma in strumento del tentativo dell’io di tornare a se stesso, di ritrovare l’identità dopo essersi soffermato sull’ineluttabilità del proprio limite. In qualche modo, anche il lettore partecipa: risucchiato dalla drammaticità di questo tentativo, ne diviene complice silenzioso; il lettore diventa una persona che ascolta da una minuscola diligenza nera trainata da cavalli bianchi.
L’Inesistente