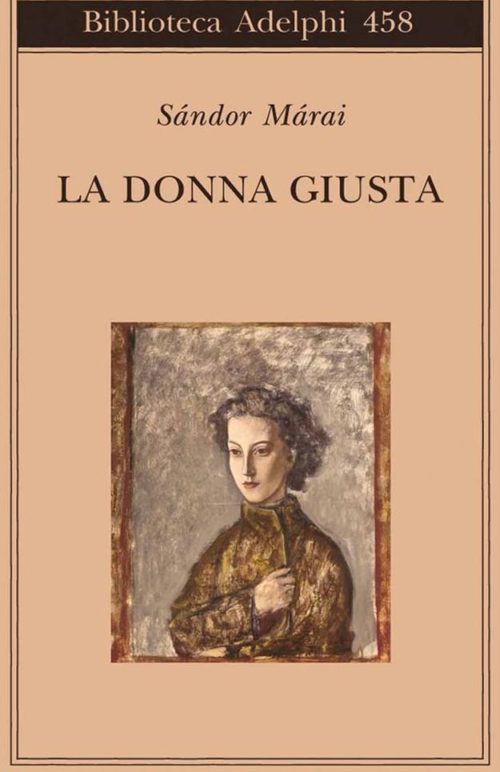Un giorno esisterà la fanciulla e la donna, il cui nome non significherà più
soltanto un contrapposto al maschile, ma qualcosa per sé, qualcosa per cui non
si penserà a completamento e confine, ma solo a vita reale: l’umanità femminile.
Questo progresso trasformerà l’esperienza dell’amore, che ora è piena d’amore,
la muterà dal fondo, la riplasmerà in una relazione da essere
umano a essere umano, non più da maschio a femmina.
E questo più umano amore somiglierà a quello che noi faticosamente prepariamo,
all’amore che in questo consiste, che due solitudini si custodiscano,
delimitino e salutino a vicenda.
Rainer Maria Rilke, Lettere a un giovane poeta, 1902-1908
Il corpo ricorda. Ricorda i tremori delle nostre attese, i sorrisi concessi e negati, le lacrime risparmiate e sacrificate. Sul nostro corpo portiamo i segni degli odori, dei suoni e dei colori che per noi hanno avuto o avrebbero potuto avere un senso. Il corpo si trasforma nel tempo, e non è solo l’involucro dell’anima, materia inerte che appare suscitando fascino e orrore, attrazione e repulsione. Il corpo tatua su di sé la storia intima dell’individuo, disegnando geometrie che si condensano o si dipanano attorcigliandosi in nuove forme secondo un moto continuo. Nel corpo si annidano passioni che emergono all’esterno come le creste affilate di iceberg solitari dispersi nell’oceano. Il corpo, nella sua vanità, nella sua inequivocabile natura effimera e troppo umana, rapisce segreti indelebili, confessati o tenuti nascosti, ma comunque febbricitanti, forieri di un messaggio che soffre, che si aggroviglia su se stesso, perché non può mai pacificamente staccarsi dal tessuto che lo ospita.
La donna giusta è un dialogo tragico tra solitudini che non si sfiorano mai. Un dialogo scisso in tre monologhi. Ciascun monologo è una diversa confessione sulla stessa tragica realtà: l’amore come non-incontro di solitudini; solitudini che invece di custodirsi, delimitarsi, salutarsi a vicenda, si annientano nella loro incomunicabilità, nella loro memoria del corpo. Mi dispiace, caro Rilke, ma per Márai le cose stanno così. L’amore, quello autentico, è sfrenato egoismo, è distruzione vegetativa, che lentamente drena amato e amante: ‘Le persone si uccidono con l’amore come un raggio invisibile e letale. Esigono sempre più amore, vogliono per sé tutta la tenerezza del mondo. Pretendono un sentimento
completo, totale, vogliono succhiare dall’ambiente che li circonda tutta la forza vitale, con la stessa avidità di certe enormi piante che senza pietà assorbono ogni energia, umidità, profumo, barbaglio di luce dagli acquitrini e da tutto il loro habitat’.
Sándor Márai, sullo sfondo dell’Europa anni Quaranta, distilla la solitudine in tre piccole ampolle, rigorosamente separate nella bacheca del suo trittico narrativo: tre personaggi – Péter, la sua prima moglie e Judit Áldozó – si passano il testimone di un enigma esistenziale in una gara che termina fra le macerie della guerra.
Lo scopo dell’amore non è la felicità. Ha una sua fenomenologia, questo sì: l’amante cerca la presenza dell’amato a qualsiasi costo, ad esempio, e se si scontra con l’inattuabilità di questa presenza, crea nella mente un’ontologia dell’assenza che possa placare (almeno virtualmente) la propria fame dell’altro. Ma questa fenomenologia – che può assumere anche la sembianza più banale di una passeggiata mano nella mano o il sigillo più grave di un’unione matrimoniale – non è amore: è vita, e tra amore e vita non intercorre alcun legame. Questo l’hanno capito tutti e tre i personaggi, al di là delle loro distanze sociali ed esperienziali. L’amore è distruttiva e totale brama di essere: ‘Un giorno si
accende il desiderio di conoscere questa passione devastante. Sai, quando ormai non si cerca l’amore per essere più sani, più tranquilli, più appagati, ma si vuole soltanto essere, in modo totale, anche a costo di perire’.
Il principio di non identità tra amore e vita su cui insiste Márai dipende dal fatto che il desiderio totale di essere, indotto nel soggetto dall’amore, non può trovare un riscontro oggettivo nella realtà, perché la realtà che viviamo non è mai assoluta: è un mosaico i cui tasselli possono formare nel loro complesso un’immagine assoluta, ma ogni tassello è in sé un contesto, e noi ci trasferiamo da un tassello all’altro – vivendo, invecchiando – mentre la figura acontestuale (l’oggetto rappresentato nella sua totalità dal mosaico) che va componendosi nel nostro movimento soggettivamente ci sfugge, sempre, anche se di tasselli ne attraversiamo mille. Il mosaico dell’amore è infinito, i tasselli non si possono contare: in questa sua oggettiva incommensurabilità sta il suo enigma, e nello sforzo – a sua volta inevitabilmente non-finito – dell’uomo di percorrerlo in tutta la sua ampiezza ristagna la nostra solitudine.
Non la felicità, ma la solitudine, secondo l’autore ungherese, è il vero scopo della vita; o meglio, la presa di coscienza del suo non poter essere sconfitta e la sua metamorfosi in patria da parte dell’individuo, disarmato e sconfitto in partenza di fronte all’impossibilità della conquista oggettiva dell’amore in questo mondo. Quella presa di coscienza implica una svolta sentimentale: se infatti quando siamo bambini la solitudine si mostra come punizione, quando siamo adulti – se inneschiamo in noi tale svolta – comincia ad apparire come consolazione, come spazio oggettivo nel quale riconoscersi e proteggere la dignità del proprio esistere.
Se non saremo mai in grado di conoscere i segreti che si celano nel cuore della persona che amiamo – in quanto ciò implicherebbe la possibilità di afferrare l’assoluto nel reale, poiché quei segreti del cuore non appartengono più alla soggettività dell’amato, proprio perché è amato, ma all’oggettività inafferrabile dell’amore – possiamo tuttavia fare della solitudine la patria dei nostri segreti. Ciò che sta in fondo a ogni vita, è il ricordo che abbiamo di noi stessi.
La memoria del corpo è la potenziale fortezza della nostra dignità umana. Passando da un tassello all’altro come lumache quadrupedi dopate dall’hic et nunc, siamo costretti a correre a una velocità né buona né cattiva ma grottesca e decisamente crudele, sbrodolando dietro di noi una bava preziosa che non riusciremo mai più a recuperare, ossia l’ingenuità.
Il concetto su cui si basa la teoria pseudosalvifica di Márai, è simile al sehnsucht abilmente sviscerato da un romantico come Friedrich Schlegel nel suo Studio della poesia greca (1797). Sehnsucht è un termine polisemico; tra le tante cose significa ‘nostalgia’ e ‘desiderio ardente’. Ecco come Márai suggerisce di difendersi dalla tragedia legata all’impossibilità oggettiva di vivere l’amore tra due soggetti che si amano: attraverso quello stesso desiderio ardente di essere che non è possibile vivere, ma che è possibile plasmare artificialmente grazie a un’interiore svolta sentimentale tesa al recupero
nostalgico dell’ingenua bava perduta.
Esiste una donna giusta/un uomo giusto? Dopo tutto quello che è stato detto, la risposta dovrebbe essere: ‘Ovviamente no, sono tutti non-giusti’. Forse è davvero così. Eppure lo stesso Márai scrive questo strambo romanzo come un interrogativo aperto (a se stesso, al lettore), lasciando adito, se non a un’alternativa alla passivamente conservatrice svolta sentimentale, a una riflessione ulteriore.
Verso la fine, Judit si imbatte per caso in Péter su uno degli ultimi ponti superstiti della Budapest squarciata dai bombardamenti. Lei, abbracciandolo, nota un’incongruenza cruciale. Il suo odore, l’odore di lui, della sua biancheria, quell’odore di fieno è ancora lì. Nonostante in città ormai tutti e tutto puzzassero di morte, quell’odore di fieno era rimasto intatto. Non si tratta di un semplice ricordo olfattivo. Il corpo assorbe frammenti di eternità. Un’eternità vissuta che orbita attorno all’amore. I due si allontano dalla folla e vanno a sedersi nella cabina di pilotaggio della carcassa di un aereo da combattimento. Partono. Non si rivedranno mai più.
Ogni uomo, giusto o non-giusto che sia, possiede un ‘quesito della creatura’, una cosa in sé kantiana che come una biglia nerotrasparente dal peso specifico inestimabile racchiude l’intera memoria del corpo (tutta l’ingenua bava perduta, per capirsi).
E questa biglia – se abbiamo la fortuna di trovarla e l’abilità di percepirla – apre uno squarcio intersoggettivo tra due solitudini per un istante fatale in cui i reciproci segreti si fondono nella loro globalità producendo amore respirabile. In altri termini, se l’amore non può essere vissuto nella sua assolutezza nel reale, noi possiamo innamorarci, e mica per finta.
L’Inesistente